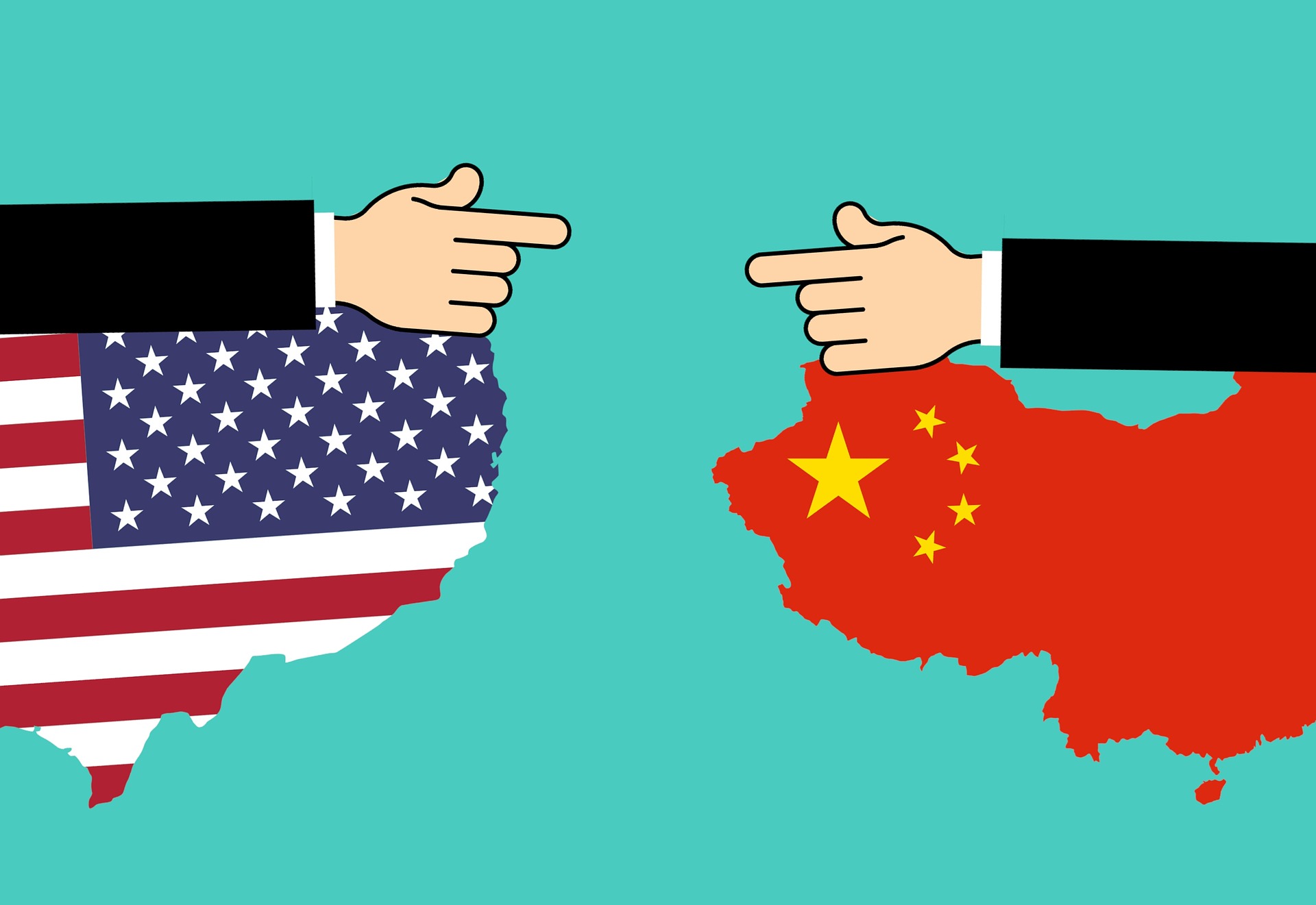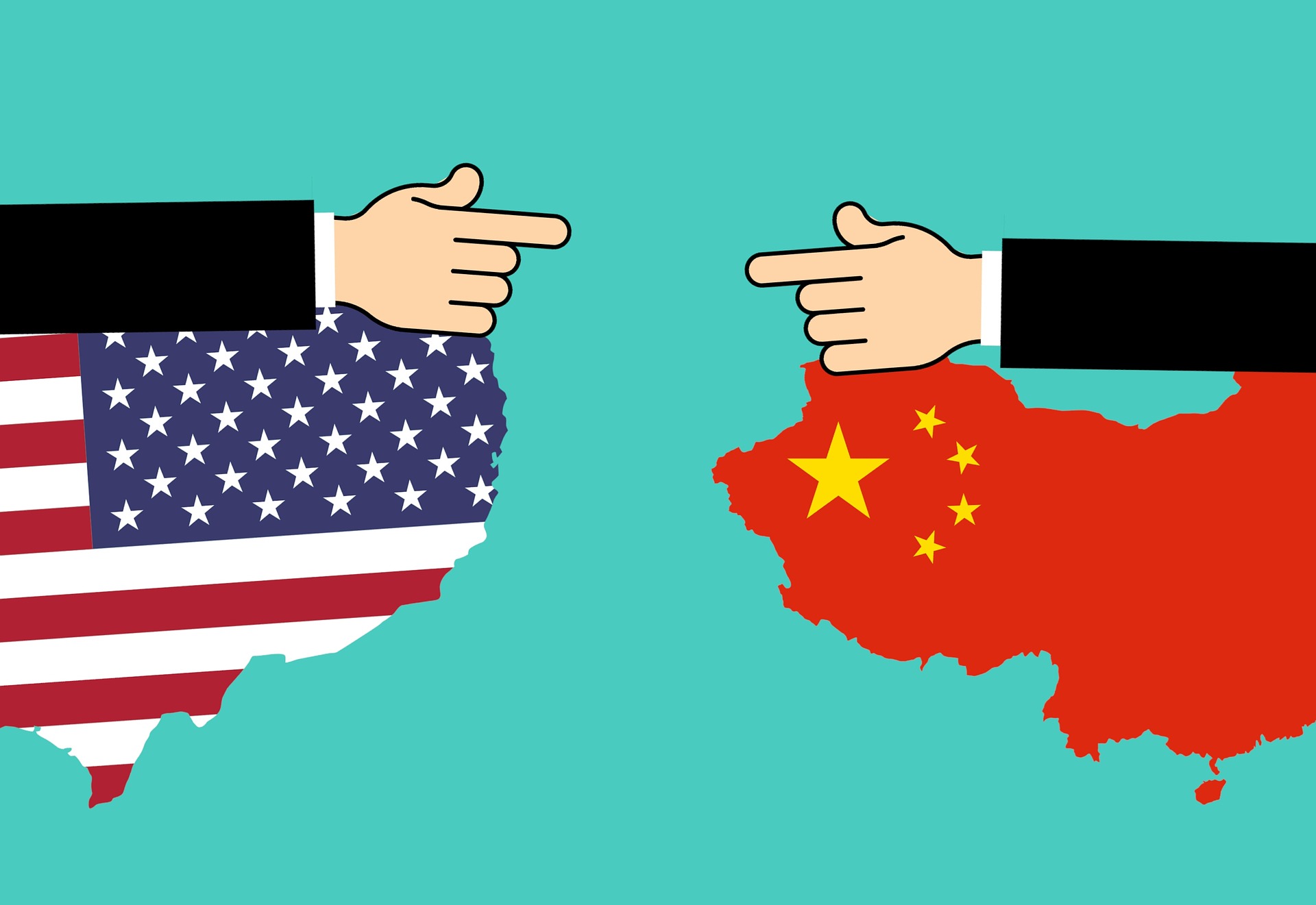
(ASI) I recenti accordi commerciali siglati tra Stati Uniti e Cina mercoledì scorso hanno avuto una enorme, planetaria eco mediatica e non poteva essere altrimenti, visto che dovrebbero essere il primo passo nella composizione di vertenze che riguardano le due più grandi economie del pianeta e che avevano tenuto studiosi, esperti ed operatori del settore col fiato sospeso fin da quando, circa due anni fa, l'inquilino della Casa Bianca aveva deciso di percorrere la strada dei dazi e delle tariffe per far valere le proprie percepite ragioni in merito.
La maggior parte dei commenti e delle valutazioni che sono state pubblicate o annunciate negli ultimi quattro giorni sulle principali testate stampate, televisive o telematiche non sono affatto oggettive o anche solo utili a capire in profondità il senso di quanto accaduto, visto che la maggior parte dei commentatori, incurabilmente faziosi, ha preferito effettuare una scrupolosa opera di cherry picking per sostanziare e ripetere la propria narrativa preferita, piuttosto che analizzare spassionatamente i fatti e addentrarsi nel terreno minato dei giudizi e delle previsioni.
I trumpiani inveterati di ogni latitudine si sono profusi in giubilo e peana per il presunto genio del POTUS che avrebbe "costretto i cinesi a cedere". Coloro che hanno eletto il miliardario immobiliarista a massimo bersaglio di biasimo e disistima si sono invece affrettati a denunciare l'incertezza, se non la vacuità, di ogni prematura dichiarazione di "vittoria". Infine quelli che - per antiamericanismo, inclinazione 'ideologica' o interessi più o meno evidenti - sostengono acriticamente ogni iniziativa e decisione avversa a Washington non hanno perso tempo a dichiarare che l'intesa raggiunta non scalfisce minimamente la continua ascesa cinese verso la vetta del sistema economico internazionale.
La situazione reale è un po' più complicata ed aperta a diversi e differenti sviluppi; come sempre necessita di una previa conoscenza di fatti ed argomenti piuttosto variegati e complessi e, soprattutto, di un abito intellettuale scevro da preconcetti per poter essere apprezzata e valutata con serenità, realismo e una ragionevole speranza di accurati pronostici.
Bisogna anzitutto ammettere che tra i trumpiani e gli anti-Trump i secondi hanno, se non ragione, comunque meno torto dei rivali, ma anche rilevare ciò non ci permette di sposarne del tutto le tesi, secondo cui l'odierno inquilino della Casa Bianca sarebbe ab origine incapace e dannoso, un atteggiamento di critica manichea ed aprioristica che noi italiani conosciamo molto bene per averlo visto applicare per quasi vent'anni dagli 'antiberlusconiani'.
Che l'accordo recentemente firmato sia stato annunciato dalla Casa Bianca e da Trump come "importante" e "notevole" e come "una correzione dei torti del passato" non è sorprendente ma logico. Che i sostenitori del POTUS, nel commentarne le dichiarazioni, abbiano dato a questo accordo della Prima Fase (perché ad esso dovrebbero seguirne altri, per comporre definitivamente le vertenze) il beneficio del dubbio, invece è quantomeno discutibile. L'articolo in merito pubblicato sul Wall Street Journal è stato misurato ma ha affermato che l'accordo "contiene vittorie per gli Stati Uniti". Il New Yorker lo ha definito una "tregua temporanea". Su CNBC, il cronista Jim Cramer lo ha ritenuto una vittoria per Trump e l'America, arrivando ad affermare che "i dazi hanno funzionato". In generale, mentre pochi al di fuori della Casa Bianca hanno visto l'accordo come trasformativo, l'accoglienza è stata amichevolmente positiva, se non altro perché sembra arrestare lo scivolamento verso ulteriori disfide dei dazi che avrebbero portato maggiore instabilità ed incertezza.
Il fatto è questo: è stato Trump ad iniziare la contesa, ad imporre barriere doganali e ad elencare, novello Lutero, le sue "Tesi di Wittemberg", secondo cui la Cina avrebbe dovuto:
- Tagliare il suo surplus commerciale verso gli Stati Uniti di almeno 200 miliardi di dollari;
- Ricompensare prontamente le compagnie statunitensi che chiedono danni per casi di proprietà intellettuale violata;
- Accettare restrizioni ai suoi investimenti nelle tecnologie "sensibili" senza replicare;
- Interrompere i suoi sostegni al settore hi-tech (aviazione, motori elettrici, microprocessori, robotica e AI);
- Aprire la propria economia a corpose partecipazioni statunitensi;
Anche volendolo interpretare nella maniera più ottimistica possibile, l'accordo di mercoledì modifica appena lo stato delle cose precedente all'arrivo di Trump alla Casa Bianca. È vero che il governo cinese si è impegnato ad aumentare le sue importazioni di beni a stelle e strisce, compresi i prodotti agricoli - soia e maiale su tutti, di cui la Cina, come noto, è fortissima consumatrice - forse perfino alla cifra di 200 miliardi di dollari contenuta nelle "Tesi" trumpiane. Ha inoltre concordato un maggiore accesso al mercato e un processo semplificato per le società statunitensi che promuovano atti legali riguardo i casi di proprietà intellettuale violata, che dovrebbero essere più rapide del processo pluriennale attualmente in vigore presso il WTO.
Tuttavia niente di quanto deciso si discosta drammaticamente da quanto la Cina aveva già concordato con la passata amministrazione Obama. Nel 2015, il presidente democratico e Xi Jinping avevano annunciato la fine del Far West sulla proprietà intellettuale, aprendo un nuovo ciclo di negoziati sull'accesso al mercato cinese. Entro il 2016, molti esperti credevano che Pechino stesse effettivamente rispettando i suoi impegni, più o meno, e che le due massime economie del mondo avrebbero "stirato" i punti ancora in sospeso in successivi incontri bilaterali.
Eppure, questo non era affatto sufficiente per molti falchi anticinesi del Campidoglio, sia repubblicani che democratici. Trump, con la sua convinzione (alcuni direbbero "fissazione") che il deficit commerciale fosse un segno di debolezza e che gli Stati Uniti ne fossero ingiustamente danneggiati, cavalcò quelle voci facendone uno dei punti caldi del proprio programma elettorale mentre, da outsider, si preparava alla vittoriosa scalata verso la Casa Bianca.
Ovviamente, una volta eletto, avrebbe dovuto dare seguito alla propria retorica elettorale. Con due anni di dazi, contro-dazi e crescente ostilità e fastidio da parte di Pechino, un accordo è stato raggiunto e, tuttavia, esso è costato agli Stati Uniti più di 30 miliardi di dollari, spesi in sovvenzioni per i produttori agricoli che hanno rischiato la rovina per le misure di risposta adottate dalla Cina. È anche costato ai consumatori americani altre decine di miliardi per acquistare beni improvvisamente divenuti più cari. Ha costretto le aziende statunitensi a diversificare le loro catene di approvvigionamento dalla Cina ad un costo aggiuntivo di altri miliardi.
Vi è un nucleo di verità nella replica trumpiana sul fatto che alcune di quelle aziende stavano iniziando a considerare mercati alternativi alla Cina anche prima del 2017, visto che essa non rappresenta più il produttore a minor costo, ma tuttavia "alcune" non vuol dire "tutte" e nemmeno la "maggior parte". Inoltre, dover spostare quelle catene di approvvigionamento in fretta e furia ha aggiunto ingenti spese all'intero processo.
L'accordo nella sua fase iniziale, quindi, ripristina a malapena gli acquisti agricoli della Cina dove erano, più o meno, prima del 2017 e, anche se questo è presentato come una vittoria, bisogna ammettere che non lo è. Allo stesso modo, la Cina nell'accordo ha accettato di fare ciò che aveva già deciso nel 2015 in materia di proprietà intellettuale, ma i due anni passati nell'ostile vertenza scatenata da Trump con i suoi dazi sono stati investiti a Pechino in un colossale processo di potenziamento del settore della tecnologia avanzata: telecomunicazioni, 5G, intelligenza artificiale, block-chain e sicurezza informatica.
Accettare di onorare la proprietà intellettuale degli Stati Uniti nel 2015 avrebbe comportato veri e propri compromessi per le società cinesi; nel 2020, tale impatto è estremamente 'smussato', il che ci porta ad altri spunti di riflessione: gli ukase di Trump riguardo l'interruzione degli incentivi cinesi all'high-tech sono assolutamente irricevibili, mentre per quel che riguarda gli investimenti cinesi nelle tecnologie statunitensi, ben presto saranno gli States a dover imprescindibilmente investire in Cina, se non vogliono trovarsi irrimediabilmente indietro dal punto di vista tecnologico.
Il caso del 5G, con gli Stati Uniti ridotti a 'sconsigliare' - se non addirittura 'minacciare' - Paesi terzi, tra cui alcuni Stati europei, dall'accettare la tecnologia cinese che promette di rivoluzionare la vita quotidiana come e più di quanto la diffusione di Internet e degli smartphone l'hanno rivoluzionata negli ultimi vent'anni, senza avere un 'proprio' 5G da proporre in alternativa, è emblematico della circostanza e rischia di ripetersi frequentemente e drammaticamente nel prossimo futuro.
Questo punto ci porta direttamente al fallimento principale della 'strategia' di Trump: essa ha fondamentalmente frainteso i punti di forza relativi sia del proprio sistema economico che di quello cinese. Ha agito come se le esportazioni cinesi negli Stati Uniti fossero la "chiave di volta" dell'economia di Pechino, contro cui quindi dazi e barriere sarebbero stati l'arma risolutiva. La Cina, in realtà, negli ultimi anni ha aggressivamente ridotto le sue esportazioni in percentuale sul prodotto interno: nel 2007, esse rappresentavano il 38% del PIL, meno di dieci anni dopo, nel 2016, erano già scese al 19%. Oggi, seppure non di molto, sono diminuite ancora.
Questa progressiva riduzione della dipendenza dalle esportazioni è stata compensata dal graduale aumento dei finanziamenti infrastrutturali a lungo termine. La Nuova Via della Seta riflette questo significativo spostamento. Quindi, per la Cina, la riduzione delle esportazioni rispetto al PIL e la riduzione del surplus commerciale verso l'estero costituivano già un obiettivo strategico desiderato e perseguito. La 'guerra dei dazi' trumpiana è stata perciò un'arma spuntata in partenza che il POTUS ha agitato per solo scopo elettorale interno, nel tentativo (vedremo quanto riuscito) di convincere i lavoratori salariati e stipendiati che nel 2016 - a sorpresa - gli diedero fiducia a concedergli nuovamente il voto nella contesa per il secondo mandato.
Da parte sua, la Cina ritiene necessario ridurre gli squilibri commerciali con gli Stati Uniti, così come vuole farlo verso qualunque altra nazione, poiché ora ha intenzione di internazionalizzare lo yuan. La Cina vuole utilizzare la propria valuta negli scambi internazionali con un numero sempre maggiore di Paesi e per questo ha bisogno di sempre meno esportazioni e più importazioni.
Forse l'obiettivo è stato quello di interrompere le relazioni economiche tra Cina e Stati Uniti, usando la proprietà intellettuale e i deficit commerciali come "tronchesi" con cui rompere i rapporti reciproci? In tal senso, questa guerra commerciale piuttosto debole e irresoluta potrebbe avere successo, ma qualcuno si chiede: "E' veramente negli interessi del 'Sistema Usa' un drastico 'disaccoppiamento' dall'economia cinese?".
Che ruolo internazionale potrebbero avere degli Stati Uniti totalmente separati dalla Cina e ad essa attivamente ostili nel resto del XXI secolo, da pochissimo entrato nella sua terza decade? Se è probabile che nel 2040 l'economia cinese avrà un valore complessivo superiore al doppio di quella statunitense ed europea sommate assieme, come previsto dall'economista Robert Fogel, una simile scelta è conveniente, o anche soltanto praticabile?
Abbiamo prima menzionato il settore tecnologico avanzato, dove la Cina in pochi anni ha fatto passi in avanti notevoli e sembra sul punto di affiancare, se non superare, in breve tempo gli stessi Stati Uniti; consideriamo per un attimo un settore a cui l'economia cinese (nella mente di molti occidentali ancora legata a fabbriche fatiscenti e a masse di operai sottopagati, come in effetti non è più da molto tempo) ancora raramente viene associata: la finanza.
Il settore finanziario cinese, un'immensa "prateria" attualmente valutata in 42.000 miliardi di dollari, è destinato ad aprirsi al mondo come mai prima d'ora. Per mantenere impegni di vecchia data e aiutare ad evitare la minaccia delle tariffe di Trump, i funzionari cinesi hanno fissato una scadenza per allentare la proprietà e le restrizioni commerciali per banche, società di valori mobiliari, gestori patrimoniali e assicurazioni sulla vita. La grande apertura finanziaria della Cina non sarà priva di rischi.
Wall Street ha bisogno di almeno un parziale ritiro delle rigide norme statali cinesi che regolano il settore prima di potervisi avvicinare con fiducia. Il conto di capitale aperto è un altro importantissimo criterio richiesto da Wall Street, affinché gli investitori stranieri sappiano con certezza che potranno incassare prontamente i loro guadagni. La Cina ha finora promesso più proprietà straniera nella sua finanza ma non si è ancora pronunciata riguardo l'apertura del conto di capitale, forse temendo una pericolosa crescita dell'influenza di Wall Street sulla propria finanza.
Tuttavia, in un'economia così vasta come quella della Cina, anche quote di mercato ad una cifra hanno la potenzialità di offrire profitti considerevoli, il che significa che il panorama finanziario mondiale non sarà più lo stesso, guarda caso proprio come l'economia produttiva e manifatturiera è stata trasformata dall'entrata cinese nel WTO. Anche con le leggi vigenti in materia di presenza statale nella finanza cinese, le attività delle banche estere in Cina aumenterebbero dai 3.200 miliardi di yuan del 2007 ai 18.800 miliardi previsti nel 2030. Il solo mercato delle assicurazioni sulla vita, nello stesso periodo, passerebbe da 193 miliardi di yuan a 2.000 miliardi di yuan.
Quindi, i profitti sarebbero potenzialmente enormi per i banchieri statunitensi anche se solo la proprietà venisse liberalizzata. Gli scambi petrolio-oro-yuan recentemente inaugurati dalla Cina hanno già conquistato il 12% del mercato dei futures nei primi 50 giorni. Sicuramente, i grandi nomi di Wall Street non possono immaginare di rimanere top player della finanza internazionale senza affacciarsi sul mercato cinese.
Il punto, come sempre, sta nel ruolo autopercepito degli Stati Uniti riguardo loro stessi, un ruolo in cui gioca non poca importanza la tradizionale ritrosia anglosassone (derivata da una cultura insulare) a percepire l'"altro" come partner e alleato, piuttosto che come cliente o servitore.
Paolo Marcenaro per Agenzia Stampa Italia