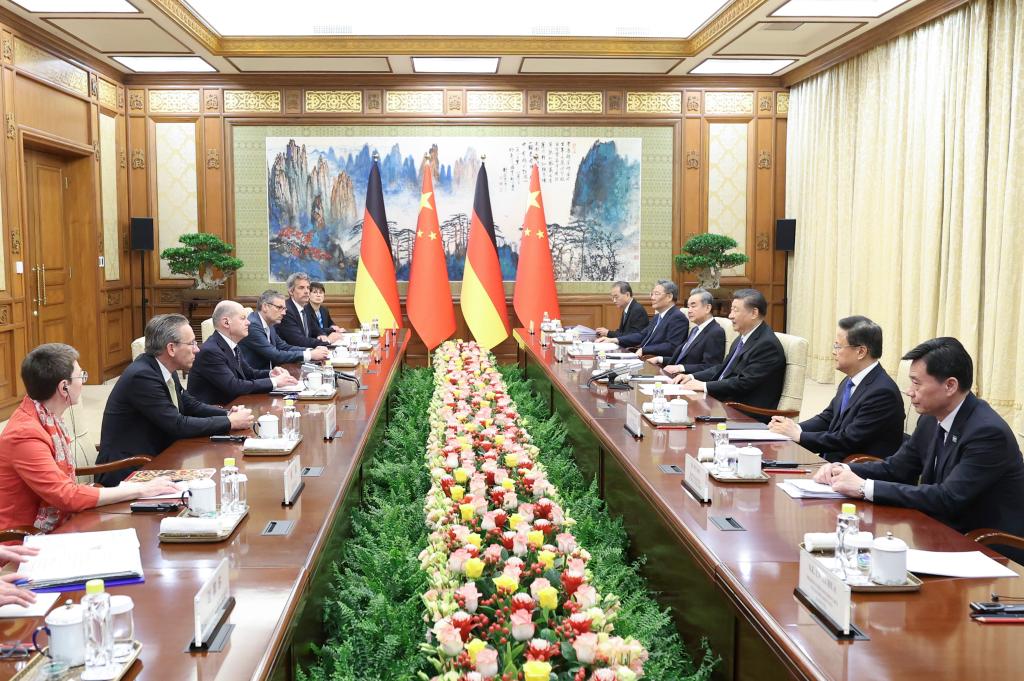(ASI) Da qualche settimana, in tutta la Cina, sono cominciate le celebrazioni per il centenario del Partito Comunista Cinese (PCC). Non soltanto appuntamenti istituzionali ma anche feste, incontri, pranzi e proiezioni luminose caratterizzano questa ricorrenza, molto sentita nel Paese. Proprio ieri, il presidente Xi Jinping ha consegnato alcune medaglie celebrative del Primo Luglio a 29 membri del PCC, alcuni dei quali scomparsi e dunque premiati in forma postuma, che hanno fornito «contributi straordinari al Partito e al popolo».
(ASI) Da qualche settimana, in tutta la Cina, sono cominciate le celebrazioni per il centenario del Partito Comunista Cinese (PCC). Non soltanto appuntamenti istituzionali ma anche feste, incontri, pranzi e proiezioni luminose caratterizzano questa ricorrenza, molto sentita nel Paese. Proprio ieri, il presidente Xi Jinping ha consegnato alcune medaglie celebrative del Primo Luglio a 29 membri del PCC, alcuni dei quali scomparsi e dunque premiati in forma postuma, che hanno fornito «contributi straordinari al Partito e al popolo».
Nel corso di questo secolo, il PCC «ha scritto uno splendido capitolo nella storia dello sviluppo della nazione cinese e in quella del progresso dell'umanità», ha sottolineato durante la cerimonia Xi, che ha aggiunto: «Generazioni di membri del PCC hanno lavorato duramente e contribuito in modo disinteressato al perseguimento dell'indipendenza nazionale e della liberazione popolare, alla costruzione di un Paese prospero e forte nonché al benessere della popolazione».
Era il primo luglio 1921 quando a Shanghai, nel segreto della clandestinità, si svolse il primo congresso dei comunisti cinesi. Presenti gli unici 53 membri, tra i quali futuri personaggi di spicco quali Mao Zedong, Dong Biwu, Chen Tanqiu, He Shuheng, Wang Jinmei, Deng Enming e Li Da. A cento anni di distanza da allora, il PCC conta 92 milioni di iscritti in tutta la Cina e governa la seconda economia mondiale, il primo mercato di produzione e consumo del pianeta, il primo mercato per investimenti in energie rinnovabili, la più estesa rete di alta velocità ferroviaria e molto altro ancora.
Nel mezzo, una lunga storia fatta di successi, fallimenti, emancipazioni, guerre, gioie e drammi. Dal primo Fronte Unito del 1924, che vedeva i nazionalisti del Kuomintang, allora al governo del Paese, alleati con le milizie comuniste per sconfiggere i signori della guerra del Nord, già indicati come "traditori della patria" dal Movimento del 4 Maggio 1919, alla Lunga Marcia del 1934-'35, quando l'Armata Rossa di Mao Zedong e Zhu De riuscì a compiere una ritirata strategica, percorrendo a piedi 12.000 km nel giro di un anno. Dalla vittoria nella guerra di resistenza nazionale contro l'invasione giapponese (1931-1945) all'ultima fase della guerra civile contro il Kuomintang (1945-1949), conclusasi con l'affermazione dell'Esercito Popolare di Liberazione e la proclamazione della Repubblica Popolare. Dalla drammatica pagina della Rivoluzione culturale (1966-1976), col suo furore iconoclasta e le sue distorsioni ideologiche, alla ricostruzione del tessuto economico e sociale a partire dal riformismo di Deng Xiaoping.
Non esiste un modo per sintetizzare questi cento anni di storia, tanto meno sottoponendoli ad un giudizio basato sui nostri criteri occidentali, come spesso l'informazione generalista tende a fare, complicando la comprensione della Cina odierna, che resta nella percezione comune un oggetto misterioso, quando non un "nemico di civiltà".
Come quasi tutti i Paesi non-occidentali, il gigante asiatico non ha conosciuto né l'illuminismo né il liberalismo. Anzi, mentre in Europa si diffondevano i principi di una rivoluzione, quella francese, non certo estranea a violenze ed atrocità, come le esecuzioni di migliaia di contadini in Vandea e negli altri dipartimenti insorti contro la Repubblica tra il 1793 e il 1815, il Continente asiatico era interessato da una nuova e più aggressiva conquista coloniale che vedeva nella ricca e prospera Cina, allora governata dalla dinastia di origine manciù dei Qing (1644-1912), la più grande delle torte da spartire.
Con la prima guerra dell'oppio (1839-1942) scatenata da Londra cominciava infatti il cosiddetto "secolo delle umiliazioni", cioè oltre cento anni di occupazioni militari, spoliazioni territoriali e repressioni civili ad opera di eserciti stranieri, intenzionati a mantenere il proprio controllo su regioni, porti ed isole usurpati alla Cina. La prima reazione alla colonizzazione del Paese e alla decadente debolezza della Dinastia Qing fu la rivolta dei Taiping (1851-1864), guidata dal profeta rivoluzionario Hong Xiuquan, che proclamò un nuovo regno "confuciano-cristiano" nella Cina sudorientale, con capitale Nanchino, finendo tuttavia sconfitto dalle truppe imperiali, supportate da Regno Unito e Francia.
Sul finire del secolo, nel 1899, quando ormai la Cina era già stata costretta a firmare una ventina di "trattati ineguali" fu invece il movimento dei Boxer (Yihetuan) a ribellarsi contro l'occupazione straniera e i missionari cristiani. Partendo dallo Shandong e dalla Grande Pianura Settentrionale, i suoi combattenti, tutti lottatori di arti marziali, scatenarono una rivolta di ispirazione nazionalista, antimperialista ed antioccidentale, appoggiata dall'Imperatrice madre Cixi. L'alleanza di otto Paesi, cioè Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Italia, Austria-Ungheria e Giappone, sostenuti da Paesi Bassi, Belgio e Spagna, sconfisse i Boxer nell'autunno del 1901, imponendo condizioni ancora più umilianti alla Dinastia Qing. Dieci anni dopo, la Rivoluzione Xinhai, guidata da Sun Yat-sen, avrebbe abbattuto la monarchia ed instaurato la repubblica, cambiando per sempre la storia della Cina.
Durante la prima sessione plenaria della Conferenza Politico-Consultiva del Popolo Cinese del 21 settembre 1949, Mao Zedong affermò non a caso: «Per oltre un secolo, i nostri antenati non hanno mai smesso di combattere inflessibilmente contro gli oppressori interni ed esterni, inclusa la Rivoluzione del 1911 guidata dal Dr. Sun Yat-sen, il nostro grande precursore nella Rivoluzione cinese». Pochi secondi dopo aggiunse: «La nostra non sarà più una nazione soggetta agli insulti e alle umiliazioni. Ci siamo alzati in piedi».
Tuttavia, quello che il PCC prese in mano alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso era un Paese gravemente impoverito, quasi completamente distrutto e privo di una classe dirigente, sterminata dai conflitti dei decenni precedenti. Basti pensare che nei soli otto anni di guerra contro l'aggressione giapponese (1937-1945), le vittime cinesi sono stimate tra i 15 e i 20 milioni, per gran parte civili. Nonostante i timidi tentativi di riforma e modernizzazione in epoca tardo-imperiale, come quelli proposti dai sostenitori del ti yong, stimolati dal contatto, pur violento e brutale, con l'Occidente, gli assoggettamenti coloniali e la crisi interna impedirono per lungo tempo alla Cina di pianificare qualsiasi concreto cambiamento politico o economico.
Ogni decisione presa dalla nuova dirigenza comunista nei suoi primi anni di governo era perciò quasi sempre sperimentale. L'aiuto dei sovietici, che presto sarebbe venuto meno, non poteva certo bastare, da solo, a risollevare le sorti di oltre mezzo miliardo di cinesi, in larghissima parte contadini. La politica dei cento fiori (1956-'57), embrionale tentativo di apertura alle libertà civili ed economiche, ritirato in breve tempo per il timore di una nuova destabilizzazione, lasciò spazio al Grande Balzo in Avanti (1958-1961), un piano di collettivizzazione forzata delle campagne che produsse scarsi risultati economici a fronte di grandi carestie. Fu così che la leadership di Mao entrò lentamente ma irreversibilmente in crisi. L'appoggio garantito dal "grande timoniere" alla Rivoluzione culturale nel 1966 fu l'estremo tentativo di mantenere, da segretario del Partito, una posizione carismatica, controbilanciando le spinte modernizzatrici e riformiste di Liu Shaoqi, che nel 1959 era subentrato a Mao alla Presidenza della Repubblica Popolare.
Le violenze scatenate dalla Banda dei quattro e dalle guardie rosse in quegli anni difficili portarono il Paese nuovamente nel caos, solo parzialmente attenuato dalla morte di Lin Biao e dall'incontro con Richard Nixon (1972), che permise alla Cina di aprirsi all'Occidente uscendo dalla condizione di isolamento internazionale in cui si era ritrovata a seguito della rottura dei rapporti con l'URSS. Dopo la morte di Mao nel 1976, Deng Xiaoping, assurto a leader di fatto, prima inaugurò una fase di ritorno alla normalità (Boluan Fanzheng) e poi diede il via alla politica di riforma e apertura, fondata sulla teoria delle quattro modernizzazioni (agricoltura, industria, tecnologia e difesa) ma anche su concetti mutuati dal pensiero tradizionale cinese, come quello confuciano di xiaokang, la "società moderatamente prospera" fissata all'inizio degli anni Ottanta quale traguardo di lungo periodo, previsto proprio per il 2021, raggiunto effettivamente pochi mesi fa con il completamento del processo di eliminazione della povertà assoluta.
La funzione storica e la missione politica del Partito Comunista Cinese rappresentano fattori del tutto peculiari, profondamente diversi dalle caratteristiche politiche delle correnti sorte dal marxismo non solo in Occidente ma anche in Russia e negli altri contesti del cosiddetto Socialismo Reale. Con la sistematizzazione dell'economia socialista di mercato (1993) e l'ingresso nel WTO (2001), il modello di sviluppo della Cina ha definitivamente imboccato un sentiero unico ed irripetibile, dunque nemmeno esportabile, definito per l'appunto come "socialismo con caratteristiche cinesi".
In un suo recente articolo dal titolo Getting CPC Right, Then Relations, scritto per China-US Focus, il Prof. Wang Yiwei, cattedra Jean Monnet presso l'Università Renmin di Pechino, ritiene che alla radice delle incomprensioni geopolitiche dei giorni nostri vi sia una scarsa conoscenza della storia cinese da parte degli Stati Uniti, che continuano ad inquadrare il PCC ed il sistema politico cinese come un'anomalia internazionale ed un problema da risolvere, condizionando a pioggia anche l'opinione pubblica dei Paesi alleati. «Per eliminare questi dubbi, il Partito deve essere inteso in termini di 100, 500 e 5000 anni».
Nel contesto storico dei cento anni, secondo il Prof. Wang, la parola d'ordine del PCC è passata da «Partito Comunista/comunismo» a «Cina/socialismo», e lo stesso socialismo è stato «sinizzato dal punto di vista del movimento, delle istituzioni e della civiltà». A partire dal Rinascimento, cominciato cinquecento anni fa, lo sviluppo dei Paesi occidentali «ha avuto un grande impatto sulla Cina, in senso sia positivo che negativo»: da un lato le ispirazioni fornite dai concetti di «democrazia» e «scienza», dall'altro il «doloroso capitolo delle invasioni coloniali», che ha spinto la Cina a ricercare un proprio percorso di sviluppo nazionale. I cinquemila anni segnano invece la storia complessiva della civiltà cinese, dalle origini ai giorni nostri. Per il Prof. Wang, «il fatto che il PCC si sia ben adattato alla cultura classica cinese» e abbia «conservato uno stato di grande unità» è la prova che la plurimillenaria civiltà «ha dato i suoi frutti», consentendo al Paese di «integrare le lezioni apprese dalla civiltà occidentale con la cultura tradizionale cinese».
Sebbene minoritaria e priva di decisionalità esecutiva, la presenza di altri otto partiti e di deputati indipendenti all'interno dell'Assemblea Nazionale del Popolo, principale organo legislativo del Paese, garantisce al sistema cinese un'embrionale ma essenziale forma di pluralismo democratico che consente di stimolare, attraverso giudizi e proposte, il dibattito interno, tutt'altro che sterile o appiattito, come molti occidentali ritengono. Pur con proprie specificità locali, un discorso analogo vale anche per Hong Kong, dove i primi elementi di democrazia diretta furono introdotti soltanto dopo il ritorno alla Cina nel 1997, eliminando la figura del governatore coloniale, fino ad allora sempre un cittadino di etnia anglosassone nominato direttamente da Londra, e sostanziando il ruolo del Consiglio Legislativo.
La riforma dello stato di diritto e la riorganizzazione degli apparati istituzionali attualmente in corso a livello nazionale dovranno adeguare l'assetto giuridico del Paese ai drastici cambiamenti socio-economici che stanno trasformando la società cinese nel suo complesso, ma sarebbe folle anche soltanto pensare di poter interferire in questo percorso sulla base di esigenze, ritmi o procedure di derivazione occidentale, cioè senza tener conto di un complesso contesto interno e fingendo che le dinamiche internazionali siano davvero fondate sulla sempre più banale e contraddittoria dicotomia "libertà/dittatura" anziché su precisi interessi strategici.
In un Paese con 1,4 miliardi di abitanti, 56 gruppi etnici ed una fittissima tela di interessi economici, commerciali, finanziari, logistici e strategici condivisi col resto del mondo, la parola d'ordine non può che essere "stabilità". E dobbiamo augurarcelo anche noi.
Andrea Fais - Agenzia Stampa Italia